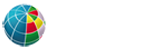L’area flegrea è soggetta a lenta deformazione del suolo nota con il nome di bradisismo (letteralmente movimento lento del suolo) che avviene con modalità diverse nel tempo, portando sia al sollevamento che alla subsidenza dell'area interessata. Il fenomeno è ben noto anche in altre caldere vulcaniche nel mondo con il nome di risorgenza calderica.

Il Serapeo a Pozzuoli
La ricostruzione dell'andamento del bradisimo ai Campi Flegrei, a partire dal IV sec. d.C. nel corso dei secoli fino ai tempi moderni è stata possibile grazie a osservazioni compiute sulle rovine di una costruzione di epoca romana, situata a poche decine di metri dal porto di Pozzuoli: il Serapeo. Erroneamente considerato come un tempio dedicato al dio egizio Serapide (da cui il nome) è stato in realtà un mercato romano dal I al II secolo AD. La peculiarità di questa costruzione è la presenza, a varie altezze sulle tre colonne ancora erette, di fori prodotti da molluschi marini (litodomi) che vivono nella fascia intertidale (tra la bassa e l'alta marea) e che quindi sono indicativi del livello marino nel passato. Grazie alla datazione di tali fori è stato possibile ricostruire le oscillazioni del livello del mare nel tempo dovute al sollevamento o abbassamento del suolo a Pozzuoli per effetto del Bradisimo.
In tempi moderni (dal 1905) le tecniche di livellazione geodetica e negli ultimi decenni anche le misure tramite GPS e i dati interferometrici, permettono di valutare in tempo reale le variazioni del suolo e quindi monitorare il fenomeno del bradisimo flegreo.

La Darsena di Rione Terra com'era in passato (a sinistra) e com'è oggi (a destra). Le imbarcazioni in secca sono la testimonianza del sollevamento del suolo dell'area.
Negli anni '70 e '80 del secolo scorso l’area flegrea, e l'abitato di Pozzuoli in particolare, sono stati interessati da un repentino sollevamento del suolo che ha portato quest’ultimo ad un livello complessivamente più alto di circa 3.5 m e causato numerosi terremoti, con gravi danni agli edifici.

In seguito la caldera dei Campi Flegrei per circa vent'anni è stata caratterizzata da generale subsidenza fino alla fine del 2005, anno in cui è iniziato un periodo di sollevamento che è attualmente in atto.

Deformazioni del suolo rilevate dalla rete GNSS dell'Osservatorio Vesuviano presso la stazione di Rione Terra dal 2000 a maggio 2025 (fonte: Bollettino di Sorveglianza mensile di giugno 2025)
La distribuzione areale del recente sollevamento vede il massimo valore nella zona del Porto di Pozzuoli, con decrescita radiale verso i bordi della caldera. Per informazioni aggiornate sullo stato delle deformazioni del suolo ai Campi Flegrei si consiglia di consultare i Bollettini di Sorveglianza settimanali dei Campi Flegrei.

Mappa degli spostamenti GNSS orizzontali (a) e verticali (b) registrati nell’area flegrea da gennaio 2023 a maggio 2025 (fonte: Bollettino di Sorveglianza mensile di giugno 2025).
La crisi bradisimica del 1969-1972
Alla fine degli anni '60 l'area di Pozzuoli era soggetta a subsidenza con una velocità media di 1,5 cm all’anno, come attestato da indagini del 1953 e confermato da rilievi del 1968. Nuovi rilievi altimetrici del 1970 mostrarono un sollevamento dell'intero abitato di Pozzuoli con il massimo valore lungo la costa immediatamente ad est del Rione Terra.

Inoltre il Serapeo si era sollevato di circa 70 cm rispetto al 1968. Furono quindi istallati nuovi sismografi presso l'Arcivescovato nel Rione Terra, al Castello di Baia e nella Grotta di Cocceio accanto al lago di Averno. Tali sismografi registrarono piccoli terremoti con epicentro sul fondo del Golfo di Pozzuoli. In base a questa informazione fu decisa l’evacuazione del fatiscente Rione Terra che non avrebbe resistito a possibili scosse sismiche più forti e ad una accelerazione del sollevamento. Nei primi mesi del 1970 vennero segnalate numerose lesioni in alcuni edifici del centro storico di Pozzuoli ed evidenze di sollevamento del suolo. Verso la fine del mese di marzo l’attività sismica si intensificò: il 26 marzo un forte terremoto fu avvertito dalla popolazione, senza però provocare danni. Nei mesi successivi le stazioni sismiche continuarono a registrare sporadici eventi sismici localizzati nel Golfo di Pozzuoli, seppure di piccola intensità.
Il sollevamento continuò fino al 1972, e raggiunse un valore massimo di 170 cm rispetto al 1968.
La crisi bradisimica del 1982-84
L'inizio della crisi bradisismica 1982-84 può farsi risalire all'estate del 1982 quando si evidenziò un sollevamento del suolo anomalo, seguito il 2 novembre da uno sciame sismico di 17 eventi in 2 ore localizzati poco a nord del porto di Pozzuoli ed avvertito dalla popolazione. Nel periodo giugno-novembre 1982 il sollevamento del suolo al porto di Pozzuoli fu stimato di circa 15 cm. Nei mesi successivi la sismicità si mantenne di lieve entità fino al 15 maggio 1983 in cui si verificò un evento di magnitudo 3.4 localizzato a Pisciarelli, nella conca di Agnano. Da quel momento la sismicità diventò più intensa concentrandosi nell'area Solfatara-Accademia. Il 4 ottobre 1983 si verificò l'evento di maggiore intensità (magnitudo 4) e il 13 ottobre si ebbe il primo sciame sismico costituito da numerosi eventi (229 eventi in poche ore). Dall'inizio della crisi fino alla fine del 1983 si registrarono oltre 5.000 eventi significativi.
Nel 1984 aumentarono il numero di terremoti di magnitudo più elevata fino all'evento di magnitudo 3.8 dell'8 dicembre. Da quel momento la sismicità diminuì drasticamente fino a cessare del tutto nel 1985.
Durante il periodo di crisi furono eseguite livellazioni geodetiche di precisione con periodicità trimestrale. Tali misure evidenziarono che il massimo sollevamento si ebbe nell’area di Pozzuoli.
Nei due anni e mezzo intercorsi dall'estate del 1982 fino a tutto il 1984 si ebbe un sollevamento dell'area del porto di Pozzuoli di circa 185 cm che, unito al sollevamento di circa 170 cm del 1970-72, portò ad un sollevamento totale di circa 3.55 m.
A cura di F. Sansivero